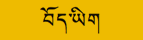Poiché tutti gli esseri senzienti
sono più preziosi del gioiello che esaudisce i desideri,
essendo intenzionato a realizzare lo scopo supremo
possa io sempre prendermi cura di loro.
Questi quattro versi riguardano la coltivazione di un sentimento di cura e affetto per tutti gli altri esseri senzienti. Il punto fondamentale messo in luce da questa strofa è la coltivazione di un atteggiamento che ci permetta di considerare gli altri esseri senzienti come preziosi, ancora più preziosi dei gioielli. Ci si potrebbe chiedere “Perché abbiamo bisogno di pensare che altri esseri senzienti siano preziosi e di valore?”
In un certo senso, possiamo dire che gli altri esseri senzienti sono la causa principale di tutte le nostre esperienze di gioia, felicità e prosperità e non solo nell’ambito delle relazioni quotidiane. Tutte le esperienze desiderabili a cui teniamo o a cui aspiriamo dipendono infatti dalla cooperazione e dall’interazione con gli altri esseri senzienti. E’ un fatto ovvio. Allo stesso modo, dal punto di vista di un praticante del sentiero, molti dei livelli più elevati di realizzazione e i progressi che si possono raggiungere lungo il cammino spirituale dipendono dalla cooperazione e dall’interazione con altri esseri senzienti. Allo stato risultante di buddhità, poi, le attività autenticamente compassionevoli di un Buddha possono sorgere, spontaneamente e senza sforzo, soltanto in relazione agli esseri senzienti, perché sono loro i destinatari e i beneficiari di queste attività illuminate. E’ chiaro dunque che gli altri esseri senzienti sono, in un certo senso, la vera fonte della nostra gioia, della prosperità e della felicità. Anche le soddisfazioni e gli agi materiali - il cibo, una casa, degli abiti e la buona compagnia - dipendono dagli altri esseri senzienti, così come la fama e il buon nome. Il nostro senso di benessere e di sicurezza dipendono da come gli altri ci percepiscono e dal loro affetto nei nostri confronti. Sembra quasi che l’affetto umano sia la base stessa della nostra esistenza.
La nostra vita non può iniziare senza affetto e il nostro sostentamento, la nostra crescita corretta e così via dipendono da esso. Per ottenere una mente calma, più ci si prende cura degli altri, più profonda sarà la nostra soddisfazione. Sono convinto che, che nel momento stesso in cui sviluppiamo un senso di responsabilità, gli altri ci appaiano in modo più positivo. E questo solo in virtù del nostro atteggiamento. Al contrario, se rifiutiamo gli altri, essi ci appariranno in modo negativo. Un altro punto che mi è piuttosto chiaro è che nel momento in cui si pensa solo a se stessi, il focus della nostra mente si restringe, facendo sì che gli eventi sgradevoli ci appaiono enormi, ci intimoriscono e ci fanno sentire a disagio. Ci si sente sopraffatti dalla sofferenza. Nel momento in cui invece pensiamo agli altri con un senso di affetto, la nostra mente si espande e, con questa prospettiva più ampia, i nostri problemi diventano insignificanti. E questo fa una grande differenza.
Con un senso di affetto per gli altri, manifesterete una sorta di forza interiore, nonostante le difficoltà e i problemi. Grazie a questa forza, i vostri problemi sembreranno meno gravi e insopportabili. Andando oltre ai vostri problemi e prendendovi cura degli altri, guadagnerete forza interiore, fiducia in voi stessi, coraggio e un crescente senso di calma. Questo è un chiaro esempio di come il proprio modo di pensare può davvero fare la differenza.
Nella Guida allo Stile di Vita del Bodhisattva (Bodhicaryavatara) si legge che esiste una differenza fenomenologica tra il dolore che si prova quando si prende su di sé il dolore degli altri ed il dolore che proviene esclusivamente dalla sofferenza personale. Nel primo caso, vi è un elemento di disagio: condividete il dolore degli altri ma, come sottolinea Shantideva, c’è anche una certa stabilità perché, in un certo senso, state accettando volontariamente questo dolore. Nella partecipazione volontaria alla sofferenza altrui c’è forza e un senso di fiducia. Nel secondo caso, invece, quando si vive il proprio dolore e la propria sofferenza, c’è un elemento di involontarietà e questa mancanza di controllo fa sentire deboli e completamente sopraffatti. Negli insegnamenti buddhisti sull’altruismo e sulla compassione, si usano espressioni come “si dovrebbe trascurare il proprio benessere e avere a cuore il benessere degli altri.” E’ importante comprendere nel giusto contesto queste affermazioni sulla pratica del condividere volontariamente il dolore altrui. Il punto fondamentale è che se non si ha la capacità di amare se stessi non c’è una base su cui costruire un senso di responsabilità verso gli altri. Amare stessi non significa essere in obbligo verso se stessi. Piuttosto, la capacità di amare se stessi o essere gentili con se stessi dovrebbe basarsi su un fatto fondamentale dell’esistenza umana: tutti noi abbiamo una tendenza naturale a desiderare la felicità e a evitare la sofferenza. Una volta che questa base esiste in relazione a se stessi, la si può estendere ad altri esseri senzienti. Perciò, quando negli insegnamenti troviamo affermazioni come “ignora il tuo benessere e abbi a cuore il benessere degli altri” dovremmo comprenderle nel contesto della trasformazione personale, in accordo con l’ideale della compassione. Questo è importante se non vogliamo ricadere in modi di pensare egocentrici, che non tengono in considerazione l’impatto delle nostre azioni sugli altri esseri senzienti. Come ho già detto, possiamo sviluppare l’attitudine a considerare gli altri esseri senzienti preziosi, riconoscendo quanto la loro gentilezza abbia un ruolo nella nostra esperienza di gioia, felicità e successo. Questa è la prima considerazione.
La seconda considerazione è la seguente: attraverso l’analisi e la contemplazione, arriverete a comprendere che gran parte della nostra sofferenza, dolore e infelicità sono il risultato di un atteggiamento egoistico, che si cura solo del proprio benessere a discapito di quello degli altri, mentre la gran parte della gioia, della felicità e di un senso di sicurezza nella nostra vita sorgono da pensieri ed emozioni che tengono in grande considerazione il benessere degli altri esseri senzienti. Mettendo a confronto questi due modi di pensare, ci si convince della necessità di considerare preziosa la felicità degli altri.
C’è un altro fatto, a proposito della coltivazione di pensieri ed emozioni che hanno al centro il benessere degli altri: il nostro interesse personale ed i nostri desideri saranno soddisfatti come “effetto collaterale” del nostro impegno verso il prossimo. Come sottolinea Je Tzong Khapa nella Grande Esposizione del sentiero per l’illuminazione (Lamrim Chenmo) “più il praticante si impegna in attività e pensieri focalizzati e diretti alla realizzazione del benessere altrui, più la realizzazione delle proprie aspirazioni personali avverranno come effetto collaterale e senza bisogno di uno sforzo separato”. Alcuni di voi potrebbero aver già sentito una frase che uso abbastanza spesso: in un certo senso i bodhisattva, i praticanti compassionevoli del sentiero buddhista, sono degli “egoisti saggi”, mentre le persone come noi sono egoisti sciocchi. Pensiamo a noi stessi, ci disinteressiamo gli altri e il risultato è che siamo sempre infelici e viviamo male. È arrivato il momento di pensare in modo più saggio, non è vero? Questa è la mia convinzione. A un certo punto sorge la domanda: “Possiamo davvero cambiare il nostro atteggiamento?”
Sulla base della mia poca esperienza, posso rispondere senza esitazione di sì. Questo è molto chiaro per me. Ciò che chiamiamo “mente” è del tutto peculiare: a volte è molto indisciplinata e difficile da cambiare ma, con uno sforzo continuo e con una determinazione radicata nella ragione, le nostre menti a volte sono abbastanza oneste. Quando abbiamo veramente la sensazione che ci sia qualcosa che vada cambiato, allora la nostra mente può cambiare. Desiderare e pregare solamente non trasformerà la vostra mente, ma con la determinazione e la ragione, basata sulla vostra esperienza personale, è possibile trasformare la vostra mente.
In questo contesto, il tempo rappresenta un fattore strategico: con il tempo, i nostri atteggiamenti mentali possono certamente cambiare. A questo punto dovrei fare una osservazione: alcune persone, specialmente chi si considera molto pragmatico, a volte diventano ossessionate dalla pragmaticità. Pensano: “Questa idea di volere la felicità di tutti gli esseri senzienti, di avere a cuore la felicità di tutti gli esseri senzienti, è utopica e troppo idealistica e quindi non ci provo neppure a lavorare per la trasformare la mia mente o per adottare un qualche tipo di disciplina mentale perché è un obiettivo irraggiungibile.” Alcune persone possono pensarla così e credere che forse un approccio più efficace potrebbe essere quello di iniziare da una cerchia ristretta di persone con cui hanno già una relazione diretta per poi eventualmente allargarla ad altri, ma non a tutti, perché sono un’infinità. Per queste persone, semplicemente non è possibile pensare a tutti gli esseri senzienti, poiché il loro numero è infinito. Potrebbero plausibilmente sentire un qualche tipo di connessione con gli altri esseri umani su questo pianeta, ma con gli infiniti esseri senzienti degli altri infiniti sistemi di universi. Potrebbero infatti domandarsi: “Che senso ha cercare di coltivare una mente che cerchi di includere nella sua sfera ogni essere vivente?” In un certo senso potrebbe sembrare un’obiezione valida, ma ciò che è importante capire in questo contesto è l’impatto che ha lo sviluppo di questi sentimenti altruistici.
Il punto è cercare di ampliare il raggio della propria empatia, in modo da poterla estendere a qualsiasi forma di vita che abbia la capacità di provare dolore e sperimentare felicità. Si tratta di definire un organismo vivente come un essere senziente. Questo genere di sentimento è molto potente, e non c’è bisogno di identificare, in termini specifici, ogni singolo essere vivente affinché possa essere efficace. Prendiamo, ad esempio, la natura universale dell’impermanenza. Quando coltiviamo il pensiero che cose ed eventi sono impermanenti, non abbiamo bisogno di prendere in considerazione ogni singola cosa o evento che esistono nell’universo per convincercene. Non è così che funziona la mente. Quindi è importante comprendere bene questo punto.
Nel primo verso, vi è un esplicito riferimento all’io: “possa io sempre prendermi cura di loro.” Forse a questo punto potrebbe essere utile una breve spiegazione sulla comprensione buddhista di che cos’è l’“io” a cui ci si riferisce. In linea generale, nessuno mette in discussione che le persone - tu, io, gli altri - esistano. Non mettiamo in discussione l’esistenza di qualcuno che subisce l’esperienza del dolore. Diciamo “io vedo questo e quello”, “io sento questo e quello” e nelle nostre conversazioni usiamo in continuazione il pronome in prima persona singolare. Non vi è alcuna disputa sull’esistenza di un “sé” a livello convenzionale: tutti noi lo sperimentiamo quotidianamente. Le domande sorgono, però, quando cerchiamo di capire che cosa siano in realtà il “sé” o l’io. Nel cercare di trovare una risposta, possiamo tentare di estendere la nostra analisi un po’ oltre la vita quotidiana e, ad esempio, ricordare noi stessi quando eravamo giovani. Quando ricordate qualcosa di quando eravate giovani, provate un forte senso di identificazione con il vostro corpo e il vostro senso di un “sé” a quell’età. Quando eravate giovani, c’era un “sé”. Quando invecchiate, c’è un “sé”. C’è anche un “sé” che pervade entrambi gli stadi. Un individuo può pensare alle sue esperienze di gioventù e alle sue esperienze di vecchiaia e così via. Ci identifichiamo con i nostri stati fisici ed il senso del “sé”, la coscienza di sé. Molti filosofi e pensatori religiosi hanno cercato di comprendere la natura della persona, quel “sé” o “io” che mantiene la sua continuità nel tempo. Nell’ambito della tradizione indiana è’ stato un tema particolarmente importante. Le scuole indiane non-buddhiste parlano di atman, approssimativamente tradotto come “sé” o “anima”; in altre tradizioni religiose non indiane sentiamo parlare di “anima” e così via. Nel contesto indiano, atman rappresenta l’agente che è indipendente dei fatti empirici dell’individuo. Nella tradizione indù, ad esempio, l’idea di reincarnazione ha dato vita a molti dibattiti. Ho persino trovato riferimenti ad alcune forme di pratica mistica, in cui una coscienza o anima assume il corpo di una persona morta da poco. Se vogliamo dare un senso alla reincarnazione, se vogliamo dare un senso all’anima che assume un altro corpo, allora dobbiamo postulare l’esistenza di un qualche tipo di agente indipendente dai fatti empirici dell’individuo.
Nel complesso, le scuole indiane non buddhiste sono più o meno tutte arrivate alla conclusione che il “sé” si riferisce proprio a questo agente indipendente o atman, indipendente dal nostro corpo e dalla nostra mente. Le tradizioni buddhiste nel complesso hanno respinto la tentazione di postulare un “io”, un atman, o un’anima indipendente dal nostro corpo e dalla nostra mente. Vi è invece consenso sul fatto che il “sé” o “io” deve essere inteso come aggregato di corpo e mente. Ma a che cosa ci riferiamo di preciso quando diciamo “io” o “sé”, è stato oggetto di divergenze di opinione perfino tra i pensatori buddhisti. Molte scuole buddhiste sostengono che, in ultima analisi, il “sé” è la coscienza della persona. Attraverso l’analisi, siamo in grado di mostrare come il nostro corpo sia una sorta di fatto contingente e che ciò che continua attraverso il tempo è in realtà la coscienza di un essere.
Altri pensatori buddhisti, invece, hanno respinto l’ipotesi di identificare il “sé” con la coscienza. Buddhapalita e Chandrakirti hanno rifiutato addirittura l’esigenza di cercare un sé eterno, costante, duraturo, sostenendo che seguire questo tipo di ragionamento è, in un certo senso, soccombere al bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Un’analisi della natura del “sé” in questo senso non porterà a nulla perché la ricerca è di natura metafisica, è una ricerca di un sé metafisico in cui, secondo Buddhapalita e Chandrakirti, stiamo andando al di là del dominio della comprensione del linguaggio e dell’esperienza quotidiane. Quindi “sé”, la persona, l’agente devono essere intesi meramente nei termini di come sperimentiamo il nostro senso di un sé. Non dobbiamo andare oltre il livello della comprensione convenzionale di “sé” e persona. Dobbiamo sviluppare una comprensione della nostra esistenza nei termini di esistenza fisica e mentale, in modo che “sé” e persona siano compresi come designazioni dipendenti da mente e corpo. Chandrakirti utilizzò l’esempio di una biga nella sua “Guida alla Via di Mezzo (Madhyamakavatara)”. Quando sottoponete all’analisi il concetto di carro, non troverete mai una carro sostanzialmente o metafisicamente reale e che esista indipendentemente dalle parti che lo compongono. Ma questo non significa che il carro non esiste. Allo stesso modo, quando sottoponiamo il “sé”, la natura di “sé” a una simile analisi, non troviamo un “sé”, che esista in modo indipendente dalla mente e dal corpo che costituiscono l’esistenza di un individuo o di essere. Questa concezione del “sé” come origine dipendente deve essere estesa anche alla nostra comprensione di altri esseri senzienti che sono, ancora una volta, designazioni dipendenti dall’esistenza fisica e mentale. L’esistenza fisica e mentale si basano sugli aggregati, che sono costituenti psicofisici degli esseri.